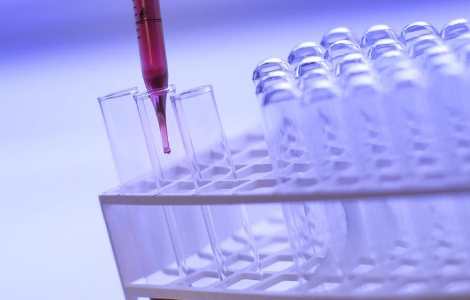Fonte: www.federfarma.it
Non cessano di stupire le scelte con cui le autorità regolatorie americane continuano ad allargare il perimetro della “selfcare medication”, l’autocura made in Usa. L’ultima arriva dalla Fda, la Food and drug administration, che nei giorni scorsi ha autorizzato la commercializzazione di un test genetico che valuta la predisposizione del paziente a una decina di malattie. Tra le quali Parkinson, Alzheimer, celiachia, malattia di Gaucher e deficit di Alfa-1-antitripsina. Un test, ed ecco la notizia, che può essere condotto in autoanalisi direttamente dal consumatore, senza la necessità della ricetta medica né del consiglio del farmacista. Da notare che alla prima richiesta della casa produttrice di registrare il test come Otc, avanzata nel 2006, la Fda aveva risposto negativamente. Nella relazione con cui ora concede parere favorevole, l’agenzia scrive invece che il prodotto «può aiutare le persone a fare scelte anticipare sui loro stili di vita, oppure avviare un colloquio con un professionista della salute».
Non mancano le controindicazioni: «E’ importante» scrive ancora la Fda «che il consumatore comprenda come il rischio genetico sia soltanto una tessera del puzzle, non predice ineluttabilmente se la persona svilupperà o non svilupperà la malattia. Ci sono altri fattori che incidono sullo stato di salute, legati all’ambiente e allo stile di vita». Le precisazioni lasciano intuire con chiarezza quali rischi potrebbero derivare da una lettura inappropriata degli esiti del test. E se è vero che la scoperta di un’eventuale predisposizione potrebbe responsabilizzare il soggetto (verso abitudini quotidiane più sane e un rapporto più regolare con medici e sanitari) è altrettanto vero che un risultato negativo potrebbe ottenere l’effetto opposto, cioè deresponsabilizzare e allontanare da una corretta prevenzione.
Questo spiega come mai la scelta dell’Fda sia stata accolta con un certo scetticismo da parecchi esperti europei. Testimoniano gli articoli comparsi su alcune riviste specializzate, dalle quali emerge lo stesso dubbio: forse, il cosiddetto “empowerment” del paziente ha valicato i suoi legittimi limiti. (AS)